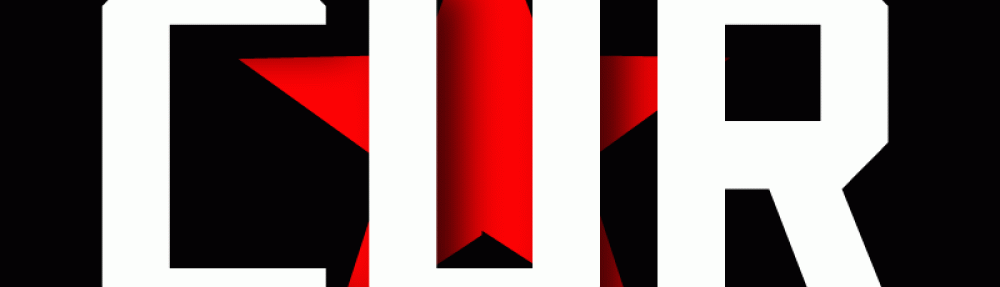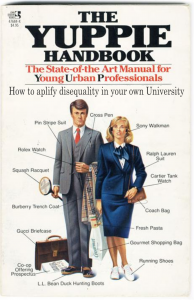…riflessioni di un compagno a partire dal covid 19…
L’Irruzione del Virus nella Storia
“I Virus sono briganti proteiformi, organismi capaci di cambiare il mondo”
– Donna Haraway, Le Promesse dei Mostri
“In un istante le si rivelò nella sua completezza la portata del suo stesso inganno,
e si domandò atterrita come avesse potuto incubare per tanto tempo
e con tanta sevizia una simile chimera nel cuore.”
– Gabriel Garcia Marquez, Amore ai Tempi del Colera
La biologa e filosofa Donna Haraway, per descrivere il nostro tempo, ha coniato il termine Chthulucene in opposizione ai soffocanti discorsi antropocentrici dell’Antropocene. Se è vero che l’impatto dell’uomo sulla terra è così devastante da essere pari ad una forza biologica, queste narrazioni riproducono la centralità dell’uomo nel nostro modo di pensare il mondo. Il Chthulucene invece, è fatto di storie multispecie, in un continuo divenire, quando il cielo non è ancora caduto ed il mondo non è ancora finito. In una temporalità aperta, nella sua precarietà dove gli esseri umani, nonostante ci piace crederlo, non sono gli unici attori rilevanti. Fino a qualche settimana fa avremmo potuto considerare questo distinguo come una sottigliezza in confronto all’apocalisse climatica e alla potenza dell’homo come deus e boia del mondo. La produzione discorsiva sulla natura come alterità è radicata nella storia del colonialismo, razzismo, sessismo e dominazione di classe di diversi tipi. Esso è alla base dell’episteme moderno che costituisce l’umano come essere allotropico che, accecato dalla luce e dal calore del ritmo produttivo delle macchine, si pone al di fuori della storia e utilizza la natura come misura della propria civiltà. La osserva come fosse il riflesso deformato di sé stesso. La manifestazione più evidente, nella sua drammaticità, è nella storia colonialismo ed il suo farsi biologico tramite la razza. Ma lo stesso ragionamento, nel suo rovescio, lo si trova nell’ambientalismo contemporaneo, nell’idea che dell’umano che deve salvare la natura, come se esso non ne facesse parte. Non difendiamo la natura, siamo la natura che si difende: e se invece che in guerra con il virus, esso fosse l’alleato?
L’inaspettato avvento di Covid-19 nelle trame della storia ci spoglia del privilegio di considerare l’homo sapiens potenza geologica indiscussa, rivelando, nel chiuso delle case, la nostra fragilità. Ci ricorda che siamo mortali, indipendentemente dalla quantità di farmaci e integratori che ingurgitiamo quotidianamente.
Ma sono i sistemi che all’interno dell’inganno, mostrano il fianco alla ferita mortale.
Il Covid-19 non è un caso o una punizione divina. Negli equilibri di un mondo sempre più precario, il virus si pone come antagonista del tardo capitalismo. La pressione di un modello di sviluppo insostenibile sul sistema pianeta genera delle reazioni in direzione opposta. Lo dimostrano i numeri sull’aumento degli spillover (o salti di specie) negli ultimi anni. SARS, Mers, Ebola e Covid-19, quattro nuovi antagonisti in meno di vent’anni. Come spiega una ricerca pubblicata sulla rivista Nature[1], le cause dell’aumento di salti di specie da animale non-umano a umano è da rintracciare nel cambiamento climatico e nel mutamento degli ambienti generato dell’uomo. Deforestazione, urbanizzazione e allevamenti intensivi in primo luogo. Tuttavia, i salti di specie non si possono fermare. Anche se si iniziasse da domani ad attuare strategie massicce di riforestazione, decostruendo e ricostruendo il nostro spazio antropico, i contatti tra le specie aumenterebbero lo stesso[2]. Centinaia di virus alla ricerca di nuovi serbatoi, per proseguire la secolare guerra che ci ha preceduto e ci succederà.
Nell’impossibilità, e mancanza di volontà, di affrontare l’altro che irrompe nella storia con la sua cieca avanzata, privo di considerazione per le nostre costruzioni culturali e sociali, di vita, di morte, di economia; il virus ci mostra e ci racconta nell’immagine del suo negativo: il corpo del mostro sociale infetto.
Il dramma del virus nel discorso egemone è nella negazione della potenza altra, il non accettare l’antagonista. Esso viene negato come altro vivente, e ridotto ad un attributo dell’umano. Non si parla dell’eterna guerra tra virus e animali, ci dicono che siamo in guerra con – e tra – umani in quanto possessori del virus. Una guerra civile. Da qui il panico, terrore, la paura, per quell’agente infiltrato, invisibile, pronto a radicalizzarsi, moltiplicarsi ed esplodere.
Non possiamo o non vogliamo accettare l’alterità, abbiamo bisogno di trasfigurarla in vesti umane: l’untore, immagine riesumata dal medioevo per nutrire l’ampia rassegna delle punizioni per chi infrange i divieti anti-contagio. Dodici anni di carcere per concorso in epidemia. Peccato solo che le nostre gabbie siano troppo larghe per rinchiuderci anche gli organismi acellulari.
Pronti alla guerra ma non all’accettazione del virus in quanto tale: un brigante proteiforme che fugge da serbatoio a serbatoio, pronto per lo sfruttamento di cellule espropriate necessarie per la sua avanzata sui corpi come forza (ri)produttiva.
Dobbiamo difendere la Società!
La reazione dell’olobionte organico è istintiva. Lockdown. Almeno per quello che raccontano. Il vero lockdown rappresenterebbe il collasso reale del sistema, come bloccare il flusso del sangue che gli permette la vita. L’unica via sarebbe l’amputazione di una delle sue parti, isolare, distinguere calcolare, riappropriarsi della possibilità di scegliere chi vive, e chi lasciar morire. Tenere in movimento solo le cellule che ne possano garantire la tenuta: le grandi industrie, la logistica, l’informazione. E mentre Confindustria continua a premere per tenere aperte le aziende, mentre gli anticorpi medici vengo usati come carne nuda ad arrangiarsi nel lazzaretto del sistema sanitario neoliberista, la narrazione sugli eroi e i cavalieri che tengono in vita il corpo-stato risuona come l’inno nazionale sulla via di Caporetto. Si canta, ma con il fucile puntato sulla schiena. Mentre il virus permea nell’epidermide della bestia, esso, impaurito continua a chiudere i confini, in una mischia selvaggia in cui, adesso, non si sa più chi lascia fuori chi e chi rimane chiuso in cosa. La lotta non è tra uomo e virus ma tra due sistemi. E se un sistema sfrutta e si appropria di corpi per riprodursi, l’altro lo attacca, rivoltando al contrario la stessa strategia, ma sfruttando la sua debolezza: bisogna salvare la società, ad ogni costo. Per questo il virus fa paura, perché è la cospirazione che esplode all’interno del sistema.
Perché in fondo vorremmo essere il nemico, il virus. Vorremmo cambiare così velocemente la nostra corporalità, considerata intrinsecamente e cronicamente malata. Vorremmo non essere così attaccati all’esistenza anche quando rischia di diventare la completa negazione di essa. Rinchiudersi, salvarsi, cercare gli untori. Appena svegli, sentiamo il bisogno di usare compulsivamente il termometro, vedere i bollettini di contagiati, morti, guariti, persi nell’’ansiogena arte del calcolare, misurare, controllare. Accendere il computer: lavarsi le mani cantando due volte happy birthday. MERRY CRISIS AND HAPPY NEW FEAR.
Perché il virus si propaga a causa delle condizioni di vita che ci sono state imposte. Vivere ammassati in megalopoli senza cielo, in città-assemblaggio frammentate, settorializzate a seconda dell’idea di vita che dovrebbero condurre chi le abita. Dai centri storici, ai centri commerciali, dalle industrie ai deserti di cemento delle periferie. Un organismo decomposto, ma connesso a velocità impossibili i cui ritmi adesso si rivoltano contro. Le infrastrutture, che con la loro velocità prima erano il simbolo del potere, adesso sono i veicoli di accelerazione di contagi che prima impossibili. Treni, aerei, metropolitane, supermercati e centri commerciali. Persino l’ospedale, nella sua configurazione moderna come istituzione totale, non può che essere cassa di risonanza per il contagio[3].
Ma non c’è nessun nuovo attacco, nessuna guerra che non era già in corso. Quanti e quante erano soggett* al ricatto di scegliere tra vita e lavoro, quanti e quante frequentavano un’università che offriva nulla se non esami e lezioni. Quanti e quante vivono per strada ed erano già sottopost* a provvedimenti repressivi criminali. Quante strade e piazze erano già vuote per la guerra contro il degrado, quanti e quante cercavano il nemico, se prima nell’immigrato, ora nel vicino di casa che fa jogging. Quanti e quante erano chius* in casa con la sensazione di non riuscire a respirare. La guerra contro la socialità, la vivibilità delle città, il diritto all’abitare, case e spazi che ci appartengono, era in corso da tempo. Il virus rende visibile ciò che prima, ai più, era nascosto. E la nostra guerra era e sarà il disgusto per le vite che vogliono farci vivere. E la combatteremo mostrando con orgoglio le ferite che lascia il passaggio dello stato di emergenza.
Del resto, l’esercizio del potere moderno è caratterizzato dalla rottura dei confini tra ciò che è biologico e ciò che è politico. Il biopotere si nutre del conatus, il vivere ad ogni costo, ottimizzando, misurando ed economicizzando la vita. D’altronde, si dirà, come si piò visualizzare amichevolmente la morte? “La battaglia non è l’unica via per indicare il processo della vita mortale”, dice Haraway, “le persone che affrontano le conseguenze, spesso mortali, del virus HiV, hanno ribadito che loro vivono con l’AIDS, piuttosto che accettare lo statuto di vittime, o di progionier* di guerra”[4]. È l’idea militaristica dell’infezione che apre gli scenari più inquietanti. E la sua decostruzione la via d’uscita.
Il primo scenario è la gestione dell’emergenza, e delle emergenze che verranno, all’interno dello stesso paradigma: controllo e militarizzazione. D’altra parte, la gestione dell’epidemia da parte dei paesi ultraliberali (UK in primis) è quella di non bloccare la macchina produttiva, con Boris Johnson che parla “di prepararsi a perdere i propri cari” espellendo già da adesso quei “cari” del corpo dell’organismo sociale. Donald Trump prova ad acquistare il brevetto di un vaccino di un’azienda tedesca chiedendo l’esclusiva per gli USA. Le meraviglie del capitalismo.
E le misure di lockdown di altri paesi, come l’Italia, per quanto potranno protrarsi nel tempo?
L’azienda DiaSorin, qualche settimana fa, ha brevettato un test diagnostico per il coronavirus che restituisce gli esiti in un’ora. E se per molti può apparire come uno strumento per salvaguardare la salute della popolazione, esso rischia di essere un nuovo strumento del (bio)potere. Come sostiene Michael Foucault in storia della sessualità, nella modernità il diritto sovrano di uccidere non poteva essere mantenuto se non minimizzando i crimini in sé e amplificando la mostruosità dei criminali: “uno ha il diritto di uccidere chi rappresenta un tipo di pericolo biologico per gli altri” (p.138). È in “nome della cura che avvengono i più grandi massacri”. Muoversi tra gli interstizi lasciati vuoti da stato e mercato sarà l’unica via possibile per fuggire da un leviatano sempre più aggressivo.
Il secondo scenario che si affaccia sugli orizzonti delle nostre finestre di quarantena è quella rizomatica espressa da Deleuze e Guattari in mille piani: l’involuzione. Essa non va confusa con la regressione, ma è una forma di evoluzione che avviene tra elementi eterogenei. L’involuzione è creatrice, non procreatrice: se regredire è andare verso il meno differenziato, involvere è formare un blocco che segue la propria linea, che diviene-altro seguendo le linee più astratte e tortuose di varie dimensioni e direzioni spezzate. Divenire rizoma significa annullare i confini tra natura e culture, abbandonare il verticalismo gerarchico delle strutture di pensiero occidentale in favore di un’orizzontalità libera, da esplorare in tutte le dimensioni possibili, senza preclusioni. Significa rivedere in maniera radicale il come viviamo, gli spazi in cui viviamo creando alleanze meticce e simbiosi transpecie. Seguendo non la nostra linea, ma la propria linea, quella di tutt*. Iniziare a vedere la natura come topos, un luogo, uno spazio in cui si condensano temi condivisi. Creare autonomia, tessere nuovi rapporti partendo dalla ricostruzione di comunità sulle necessità. Creare orti e mercati di quartiere, socializzare le tecniche, un patrimonio condiviso che troppo spesso è stato silenziato. Rompere le relazioni basate sull’estrattivismo, ricreare lo spazio urbano come spazio “improduttivo”, riappropriandosi di quelle conoscenze legate ai luoghi. E ripartire da lì.
“La natura è, strettamente, un luogo comune”[5].
R.D.
[1] https://www.nature.com/articles/nature06536
[2] https://www.iltascabile.com/scienze/spillover-coronavirus/
[3] https://www.fanpage.it/attualita/coronavirus-lallarme-di-ilaria-capua-in-lombardia-sta-succedendo-qualcosa-che-non-si-spiega/
[4] Donna Haraway, Le Promesse dei Mostri, p.24
[5] Donna Haraway, Le Promesse dei Mostri