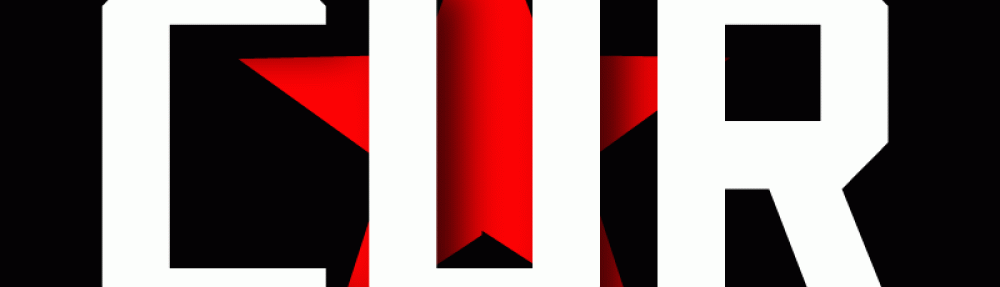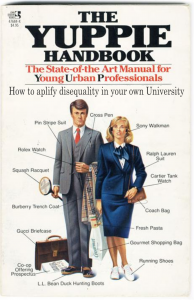pubblichiamo delle interessanti riflessioni di un fuorisede a Trento ai tempi della pandemia.

Mi sono trasferito a Trento durante una pandemia globale che sta mettendo in ginocchio milioni di persone, frantumando progetti e psiche già duramente provate dalle strutture e oppressioni di questo maledetto tardocapitalismo. Ho incontrato ciò che migliaia di studenti fuorisede hanno conosciuto prima di me e che continueranno a conoscere per molto tempo: affitti folli, padroni di casa di merda, supermercati con prezzi ben oltre la mia portata e strade con più sbirri che panchine. Non basta, ho conosciuto quella particolare tendenza trentina a voler aumentare il numero di studenti a dismisura ma soltanto a lezione, con la speranza che cessino di esistere oltre la loro partecipazione accademica e non si facciano vedere per le strade per esempio volendo uscire la sera. Non intendo certo riprodurre il trito e ritrito luogo comune della guerra tra residenti e studenti, mi annoia abbastanza, ma credo che quanto detto da un’amica, cioè “qui a Trento non hanno ancora capito come spremere del tutto il portafoglio di noi fuorisede lasciandoci ammassare in luoghi di aggregazione a prezzi più bassi”, basti per riassumere la situazione generale. A cui si aggiunge la già citata stramaledetta pandemia che rende il tutto ancora più pesante e difficile. O forse no. Il coronavirus ha un pregio, il pregio di tutte le crisi incontrollabili: mettere a nudo le contraddizioni e costringere a pensarci, a darci un peso. Se non ci fosse la quarantena, il coprifuoco, il lockdown, l* poch* compagn* conosciut* in queste brevi settimane che scompaiono perché il sistema di tracciamento dei contatti dei positivi l* risucchia in una spirale di ansie e tamponi, forse la domanda “che ci fai a Trento?” avrebbe un significato diverso. Un anno fa avrei potuto arrampicarmi sui vetri, giustificare la mia presenza in questa città per le lezioni, il contatto con le persone, la (poca) vita universitaria. Ora tutto questo non esiste più. Le lezioni si seguono da casa e, a conti fatti, ci si rende conto che cambia poco, che la conoscenza verticale continua a franarti addosso anche se adesso puoi togliere audio e video e mandare a fare in culo i professori quando fanno la solita sparata maschilista o discriminatoria. E anche tutto il resto, come possiamo vedere facendo un giro davanti a una scaletta ormai svuotata (non ho fatto in tempo a provare lo champagnone, mannaggia al capitalismo), non si trova più. Dunque, perché sono a Trento? Per un’entità che nella mia mente si presenta astratta ma in realtà è tremendamente tangibile, materiale e prepotente: l’Università. Ottima risposta, ma quale università? Vale la pena approfondire meglio questo aspetto, tanto non abbiamo più nulla da fare oltre a qualche timido aperitivo, almeno finché ce lo fanno fare. L’ateneo tridentino è infatti primo nella classifica MIUR degli atenei di media dimensione italiani. Qualità dell’insegnamento alle stelle, strutture futuristiche, professor* disponibili. Per carità, forse in alcuni casi fortunati le aspettative verranno soddisfatte, ma per quanto riguarda la maggioranza siamo qui perché ci vendono, e a caro prezzo, un’idea di università che non esiste e la promessa di un futuro che manca. Ti raccontano che non si tratta del solito parcheggio per studenti che serve a non farci accorgere che non ci stanno lasciando nulla su sto pianeta, che dovremo fare la fame fino a quarant’anni per morire di cancro o climate change ai cinquanta. Il covid mi costringe a fare i conti con questo, sono uno studente fuorisede che studia in un’università che riproduce uno schema meritocratico-competitivo e oppressivo profondamente capitalistico come tutte le altre. Sono solo un po’ più privilegiato rispetto a chi studia in un ateneo di serie B, posso succhiare qualche ridicola goccia in più di un benessere negato alla maggioranza di cui faccio parte. Si, ho delle agevolazioni da studente, più di quelle che avevo nell’ateneo dove ho fatto la triennale. Ma a parte questo sono solo un piccolo ingranaggio in una catena di montaggio culturale, pago per esserlo, fatico per raggiungere uno status sociale classista di laureato che non mi porterà nulla se non forse uno sfruttamento leggermente meno peggiore di chi non è tanto privilegiato come me da potersi permettere di studiare. E mi rendo conto più di prima che io sono un numero di matricola, lo sono sempre stato e lo sarò fino alla laurea, questa università provvederà a mettermi dei numeri in trentesimi da associare a dei codici di esami finchè continuerò a pagarla regolarmente e mi vomiterà fuori inerme, catapultandomi dentro a una società profondamente ingiusta e disinteressata alla mia sorte. Fermiamoci un secondo. Tutto questo lo sappiamo già, chiunque abbia mai partecipato a un’assemblea universitaria ma anche liceale avrà già sentito gli slogan, condivisibili e legittimi come tutti gli slogan del resto, del tipo “no alla scuola dei padroni”. C’è qualcosa di diverso questa volta. Qualcosa che va più a fondo, che parte dalla didattica a distanza e arriva in un punto di indefinito malessere e rabbia. Perché diciamocelo, la didattica a distanza funziona fottutamente bene. Funziona nell’ottica di un’università fabbrica di cfu, è il tipico riciclo del capitalismo che trova il modo di salvarsi il culo a ogni fottuta crisi che provoca. Ecco la novità, ecco cosa non funziona: davanti a una crisi sanitaria profonda che comporta disastri psicologici ed economici per tutt* noi, l’università ha trovato il modo di andare avanti senza mettere in discussione nessuna delle sue strutture, nessuna delle sue finalità. L’università sta andando avanti senza noi, nonostante noi, questa volta in maniera più plateale del solito. Quando guardo i riquadri vuoti e neri di quell* che dovrebbero essere l* compagn* di corso, mi rendo conto che in questo schema, è possibile un’università senza studenti. Non solo è possibile, è auspicabile per il capitale. Qualsiasi spazio lasciato all’ultima ruota del carro della struttura accademica è scomparso. Non parlo solo di spazi fisici ma anche virtuali, solidali, organizzativi e politici. Resta una struttura svuotata, che almeno prima fingeva di voler essere riempita con le nostre idee e i nostri corpi, ora non più. Non c’è una comunità studentesca, non ci sono l* studenti, siamo gettati davanti alla nostra fragilità fisica come mai prima nella nostra vita e nonostante questo, nonostante questa mancanza violenta, questo vuoto incolmabile, l’università va avanti. Perché perdere mesi di lezione non si può, bisogna restare competitiv* e formare nuove vittime del mercato del lavoro in fretta. Non è servita una fottuta pandemia per mettere un freno all’università neoliberista, ad aprire la possibilità di una ridefinizione di cosa debba essere per noi questo luogo. E se il luogo che si professa come tempio del sapere e della discussione (tante belle parole) non è in grado di rimettersi in discussione, allora abbiamo un problema che va ben oltre le tasse, ben oltre i saperi liberi e accessibili, ben oltre gli spazi fisici in cui studiare.
Il covid congela tutto, congela questo mondo accademico in cui prima mi muovevo liberamente e mi toglie quelle distrazioni che mi facevano distogliere lo sguardo da questa verità: ci hanno intortato per anni e continuano ancora dicendoci che lo studio serve ad emanciparsi. Forse avrebbero dovuto insegnarci a disertare le strutture della conoscenza istituzionalizzata e neoliberista e ad assaltarne i palazzi. Ma lo stiamo imparando da sol*.
Ora so cosa ci faccio a Trento durante una pandemia globale: a Trento mi arrabbio. O forse sono sempre stato arrabbiato e Trento me lo fa ricordare.